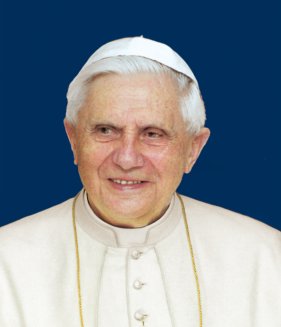Giovanni Paolo II e Benedetto XVI
È
dinanzi ai nostri occhi l’esempio del mio amato e venerato
predecessore Giovanni Paolo II , un Papa missionario, la cui attività
così intensa, testimoniata da oltre cento viaggi apostolici
oltre i confini d’Italia, è davvero inimitabile. (Benedetto XVI: dall’omelia del 25/4/2005, in S. Paolo fuori le mura) |
 “Habemus
papam”
“Habemus
papam”
Siena, Chiesa di San Niccolò in Sasso. Sono le ore 18 circa del
19 aprile 2005. Sono stato invitato a presentare il volume di mons. Walter
Brandmüller, docente di Storia della Chiesa ad Augsburg, in Baviera,
e Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il titolo dell’opera
è carico di significati, anche per il momento storico attuale:
Il Concilio di Pavia-Siena (1423-1424). Verso la crisi del conciliarismo.
In questo piccolo gioiello, inglobato nei locali dell’Opera della
Metropolitana di Siena sto parlando, sotto il profilo storico, della Chiesa
universale, di Caterina da Siena (di Colei che soleva rivolgersi al Papa
come al “dolce Cristo in terra”), del Grande Scisma d’Occidente,
di papato e collegialità, di divisioni e ricomposizioni, non senza
fare un breve cenno all’apertura agli studiosi dell’Archivio
Segreto Vaticano grazie alla lungimiranza del S. Padre Giovanni Paolo
II, scomparso da pochi giorni, e del cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto
della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Rettore della Metropolitana,
che presiede alla cerimonia, mi interrompe per una comunicazione urgente…
hanno eletto il nuovo Papa! L’applauso nasce spontaneo, il campanone
del Duomo suona a distesa. Cerco di proseguire non senza fatica: non ho
un testo scritto ma, come al solito, un fitto canovaccio di appunti. “Chi
avranno eletto?”: è la domanda che in questo momento, nel
totale silenzio degli astanti, sta attraversando la navata unica della
piccola chiesa, in un abbraccio ideale con tutta la cristianità,
mentre proseguo l’illustrazione dell’opera, pregevolissima,
dell’amico e collega tedesco. La cerimonia volge al termine. I convenevoli
che, di solito, sono lunghissimi, si limitano, questa volta, allo stretto
indispensabile. Corriamo tutti a casa. “Annuntio vobis gaudium magnum,
habemus papam..”. La voce stentorea del cardinale protodiacono mi
accoglie proprio mentre sto rientrando. “…Eminentissimum ac
reverendissimum dominum, dominum Josephum, Sanctae Romanae Ecclesiae,
cardinalem Ratzinger…”. La piazza, anche quella mediatica,
dopo un lunghissimo applauso ammutolisce… Attende un nome, quel
nome che nella tradizione cattolica riveste sempre un grande significato
“…qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI”. Una nuova
pagina di storia si è aperta.
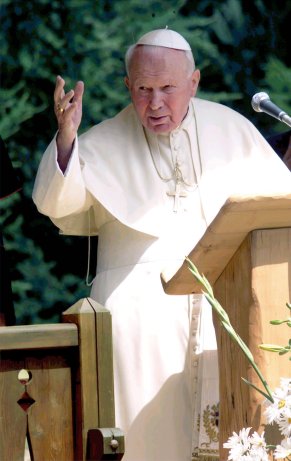 Giovanni
Paolo, il grande missionario
Giovanni
Paolo, il grande missionario
Dopo oltre ventisei anni di pontificato, uno fra i più lunghi della
storia, Giovanni Paolo II ci ha lasciato alle 21,37 del 2 aprile 2005.
Giornalisti e scrittori, uomini di cultura e semplici cittadini, potenti
e ultimi della terra, uomini di Chiesa e atei convinti, si sono inginocchiati
di fronte alla grandezza di un Papa che ha segnato indelebilmente il quarto
di secolo a cavaliere tra la fine del secondo millennio e l’inizio
del terzo. Le folle che si sono accalcate in piazza san Pietro per dare
un ultimo saluto al Pontefice hanno destato una grande impressione: ci
si è interrogati, infatti, sul valore da attribuire ad un evento
di questa portata. Gli aggettivi, talvolta fra loro contraddittori, si
sono sprecati: Karol il Grande, conservatore e progressista, Papa mediatico,
Papa dei giovani e delle folle, l’uomo che ha sconfitto il comunismo,
l’atleta di Dio, l’uomo dei viaggi in tutto il globo, il Papa
mistico. Ed ancorché tutte queste aggettivazioni abbiano un indiscutibile
fondamento, esse dimostrano la fretta, figlia di questa nostra epoca,
con la quale si desidera racchiudere in un breve motto una vicenda complessa
e talvolta drammatica, che ha visto protagonista il Papa polacco. Ed ancorché
un giudizio storico su questo pontificato non possa e non debba essere
frutto dell’emozione del momento, perché l’analisi
dei fatti richiede una lunga decantazione unita ad una loro conoscenza
profonda, non possiamo fare a meno di soffermarci, per un momento, su
una delle maggiori peculiarità che hanno caratterizzato l’azione
e l’opera di Giovanni Paolo II: la sua missionarietà.
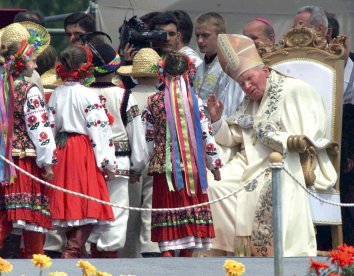 Fin
dall’inizio del suo pontificato che destò, non dimentichiamolo,
tanti interrogativi in chi volle vedere esclusivamente il profilo per
così dire eminentemente “politico”, Giovanni Paolo
II chiamò tutti ad assumersi una grande responsabilità:
“aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo”. Tradurre in
pratica questo imperativo che assunse, proprio nel giorno di inaugurazione
del suo pontificato, i toni della preghiera e dell’umile richiesta
(chi non ricorda quell’espressione “vi imploro” che
eravamo poco abituati a sentire dalla bocca del Papa), è stata
la linea guida di questi ventisei anni. Giovanni Paolo II, infatti, ha
posto l’uomo al centro della sua azione pastorale. Giovane o anziano
che fosse, sano o malato, ricco o povero, potente o umile, l’uomo
ha avuto in Giovanni Paolo II non solo una guida spirituale ma un vero
testimone della fede. E l’uomo venuto da lontano, che aveva vissuto
sulla sua pelle il dolore della morte, la violenza della guerra, della
persecuzione ideologica e la negazione della libertà religiosa
e che aveva assistito, impotente, allo sterminio dei deboli e degli inermi,
divenuto Papa ha contribuito con tutte le sue forze, ed in maniera determinante,
al mutamento della vicenda umana. La missione di Giovanni Paolo II si
è sostanziata, quindi, nel restituire all’uomo la sua dignità,
la sua centralità, il suo ruolo insostituibile nel divenire della
storia. Non possiamo dimenticare, inoltre, se vogliamo scendere maggiormente
nello specifico proprio di questa nostra Rivista, la grande attenzione
che questo Pontefice ha riservato ai popoli in via di sviluppo ed alla
necessità di annunciare la salvezza dell’uomo in Cristo Gesù:
un compito affidato innanzitutto ai missionari, a coloro cioè che,
pur in situazioni di gravissima difficoltà se non di stringente
pericolo, si sono fatti essi stessi testimoni della fede fino al martirio.
Fin
dall’inizio del suo pontificato che destò, non dimentichiamolo,
tanti interrogativi in chi volle vedere esclusivamente il profilo per
così dire eminentemente “politico”, Giovanni Paolo
II chiamò tutti ad assumersi una grande responsabilità:
“aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo”. Tradurre in
pratica questo imperativo che assunse, proprio nel giorno di inaugurazione
del suo pontificato, i toni della preghiera e dell’umile richiesta
(chi non ricorda quell’espressione “vi imploro” che
eravamo poco abituati a sentire dalla bocca del Papa), è stata
la linea guida di questi ventisei anni. Giovanni Paolo II, infatti, ha
posto l’uomo al centro della sua azione pastorale. Giovane o anziano
che fosse, sano o malato, ricco o povero, potente o umile, l’uomo
ha avuto in Giovanni Paolo II non solo una guida spirituale ma un vero
testimone della fede. E l’uomo venuto da lontano, che aveva vissuto
sulla sua pelle il dolore della morte, la violenza della guerra, della
persecuzione ideologica e la negazione della libertà religiosa
e che aveva assistito, impotente, allo sterminio dei deboli e degli inermi,
divenuto Papa ha contribuito con tutte le sue forze, ed in maniera determinante,
al mutamento della vicenda umana. La missione di Giovanni Paolo II si
è sostanziata, quindi, nel restituire all’uomo la sua dignità,
la sua centralità, il suo ruolo insostituibile nel divenire della
storia. Non possiamo dimenticare, inoltre, se vogliamo scendere maggiormente
nello specifico proprio di questa nostra Rivista, la grande attenzione
che questo Pontefice ha riservato ai popoli in via di sviluppo ed alla
necessità di annunciare la salvezza dell’uomo in Cristo Gesù:
un compito affidato innanzitutto ai missionari, a coloro cioè che,
pur in situazioni di gravissima difficoltà se non di stringente
pericolo, si sono fatti essi stessi testimoni della fede fino al martirio.
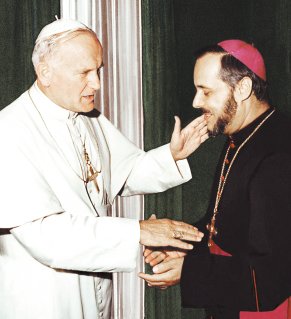 Come
dimenticare, quindi, i viaggi apostolici nel corso dei quali ha potuto
conoscere direttamente la situazione dell’Africa, dell’Asia
e dell’America Latina, dando grande slancio alle Chiese giovani,
facendosi egli stesso missionario; come non sottolineare la celebrazione
dei Sinodi dedicati alla situazione dei vari continenti inseriti nel più
ampio disegno costituito dall’Enciclica Redemptoris Missio, con
la quale si apriva lo sguardo alla evangelizzazione del Terzo Millennio;
come non rimarcare, infine, il grido, per lo più inascoltato, della
“remissione del debito” ai Paesi del Terzo Mondo, lanciato
in occasione del Grande Giubileo del 2000: un momento che avrebbe dovuto
rappresentare un nuovo punto di partenza nella relazioni fra Paesi ricchi
e Paesi poveri, finalizzato soprattutto ad instaurare rapporti di pacifica
collaborazione e non di sfruttamento da parte degli uni nei confronti
degli altri. Una grande fede, un grande slancio ecumenico e autenticamente
missionario, uno spirito aperto al dialogo con tutti hanno caratterizzato
il pontificato di Giovanni Paolo II: al suo successore lascia una grande
eredità ed una altrettanto grande responsabilità.
Come
dimenticare, quindi, i viaggi apostolici nel corso dei quali ha potuto
conoscere direttamente la situazione dell’Africa, dell’Asia
e dell’America Latina, dando grande slancio alle Chiese giovani,
facendosi egli stesso missionario; come non sottolineare la celebrazione
dei Sinodi dedicati alla situazione dei vari continenti inseriti nel più
ampio disegno costituito dall’Enciclica Redemptoris Missio, con
la quale si apriva lo sguardo alla evangelizzazione del Terzo Millennio;
come non rimarcare, infine, il grido, per lo più inascoltato, della
“remissione del debito” ai Paesi del Terzo Mondo, lanciato
in occasione del Grande Giubileo del 2000: un momento che avrebbe dovuto
rappresentare un nuovo punto di partenza nella relazioni fra Paesi ricchi
e Paesi poveri, finalizzato soprattutto ad instaurare rapporti di pacifica
collaborazione e non di sfruttamento da parte degli uni nei confronti
degli altri. Una grande fede, un grande slancio ecumenico e autenticamente
missionario, uno spirito aperto al dialogo con tutti hanno caratterizzato
il pontificato di Giovanni Paolo II: al suo successore lascia una grande
eredità ed una altrettanto grande responsabilità.
Benedetto:
“Allora andiamo”
“Benedetto XVI”. Il nome che Joseph Ratzinger ha scelto è
altamente significativo. Benedetto, come il santo di Norcia, compatrono
d’Europa, come colui che dal “nido di rondine” del Sacro
Speco di Subiaco, dopo aver attraversato gran parte del Basso Lazio, eresse
sulla rocca di Montecassino il monastero che avrebbe irradiato il cristianesimo
in tutto l’Occidente: un luogo di altissima cultura e di grandissima
spiritualità, ma simbolo, nel recente passato, di come la barbarie
umana possa riuscire a distruggere anche le opere più elevate dell’uomo.
“Benedetto” come il suo predecessore dell’inizio del
secolo scorso, il genovese Giacomo Della Chiesa (1914-1922), l’uomo
che definì la I Guerra Mondiale “una inutile strage”,
che tentò, inutilmente, di far cessare quel conflitto che avrebbe
indelebilmente segnato la storia della prima metà del secolo scorso,
ma anche l’uomo del dialogo con i fratelli separati e con le altre
fedi.
|
Cercare di comprendere o
di intuire quale sarà il profilo pastorale di Papa Ratzinger è
opera inane: nessuno può prevedere il futuro. È certo però
che il suo passato, un passato di studi teologici di altissimo livello,
di grandi responsabilità all’interno della Chiesa non può
non lasciare il segno anche se, come lui stesso ha già detto, si
porrà soprattutto in ascolto e cercherà di fare non la sua
volontà ma quella di Dio. Ed anche le omelie da lui recentemente
tenute possono indicare alcune delle vie che molto probabilmente percorrerà:
sarà un uomo di pace perché contrasterà tutti coloro
che vorranno portarci ad uno scontro di civiltà, difenderà
l’identità cristiana ma dialogando con tutte le altre fedi,
combatterà duramente contro il relativismo etico (come ha espressamente
affermato in occasione della Santa Messa “pro eligendo Romano Pontifice”)
e, allo stesso tempo, tutelerà la dignità degli uomini e
dei popoli, soprattutto di quelli più indifesi. Forse la sua missionarietà
non si caratterizzerà per i grandi slanci che hanno pervaso il
pontificato del suo grande predecessore, forse non susciterà le
grandi emozioni alle quali ci aveva abituato Giovanni Paolo II, ma la
sua proposta è, con le parole di Gesù, molto chiara: “Vi
ho costituito perché andiate, e portiate frutto, e il frutto rimanga”.
È la santa inquietudine - per usare le sue parole - che tutti ci
deve pervadere, perché tutti siamo chiamati a portare agli altri
il dono della fede, dell’amicizia con Cristo: Egli, infatti, ci
ha chiamati amici.
Benedetto XVI ci ha già ricordato le nostre responsabilità
proponendo una riflessione profonda sul nostro essere cristiani. Cosa
resterà di noi? Il denaro che avremo accumulato e per il quale
siamo disposti a compiere le azioni più abbiette, le opere dell’uomo
che vengono spazzate via dai venti di guerra, i nostri libri che, spesso,
sono motivo di orgoglio e testimoni di una sapienza destinata, però,
ad essere superata dopo poco tempo? “Il frutto che rimane è
quanto abbiamo seminato nelle anime umane… il gesto capace di toccare
il cuore, la parola che apre l’anima alla gioia del Signore”.
“Allora andiamo….”! È questo il motto di Benedetto
XVI. No, non credo che sarà un Papa il quale, come da taluno si
è scritto, si arroccherà su posizioni dottrinali per chiudersi
nelle sue certezze.
I tanti deserti che caratterizzano la storia dell’umanità
contemporanea, deserti spirituali e materiali, deserti di fame e di povertà,
di sfruttamento e di distruzione trovano un’unica risposta nel Cristo,
in colui che, da Pastore del suo gregge, si è fatto agnello per
porsi dalla parte dei calpestati e degli uccisi. Ecco allora perché
una delle immagini contenute nell’Epilogo del Vangelo di Giovanni,
può racchiudere sinteticamente il suo programma, che non è,
come egli ha detto, un programma di governo, ma il programma del Buon
Pastore: “Sequere me”! “Seguimi”! È questo
l’invito del Cristo rivolto a Pietro e che ora viene rivolto anche
a noi per il tramite del successore: seguimi nel mondo, evangelizza il
mondo, promuovi l’uomo nella sua interezza! Sarà un Papa
autenticamente missionario!q