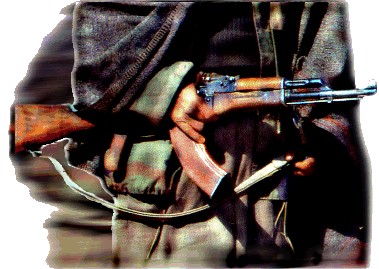 Il
coraggio della pace
Il
coraggio della pace
Se
per pace si intende un bene da perseguire attraverso la guerra, un bene
al quale è lecito, anzi doveroso, sacrificare la vita (degli altri),
da presidiare incrementando gli arsenali, magari atomici, e rispondendo
con rappresaglie esemplari (bombardamenti) ad episodi che potrebbero metterla
a rischio (lancio di pietre), non è di questa pace che intendiamo
parlare.
Se per pace
intendiamo il mantenimento dell’ordine, in cui alcuni (persone, stati
o governi) perseguono il loro arricchimento, attraverso il lavoro di altri
(persone o nazioni), deliberatamente mantenuti in condizioni subumane,
ad evitare il rischio che questi familiarizzino con concetti come diritto
e giustizia, non è di questa pace che intendiamo parlare. La pace
che ci interessa è quella di Gesù “Vi lascio la pace,
vi do la mia pace, non come la dà il mondo io la do a voi”
(Gv.14,27); quella propria dei figli di Dio “Beati gli operatori
di pace perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt.5,9); la
stessa vissuta e donata da San Francesco e dai suoi figli, a tutti coloro
che incontrano, un saluto ed un augurio tanto semplice e incommensurabile
“Pace e Bene”.
Ci interessa perché ha a che fare con la missione, sempre e dovunque,
quindi anche qui e ora. La missione -i nostri fratelli che la vivono in
terre lontane ce lo insegnano- è soprattutto dono gratuito di sé
stessi; è accoglienza dell’altro, specie se diverso, se antipatico,
se rancoroso, se violento, se malvagio; è capacità di andare
oltre l’apparenza, e saper scorgere quel barlume di divino che è
nel mistero di ogni uomo. Per questo il missionario è, prima di
tutto, uomo di pace. Per questo la pace è, prima di tutto, qualcosa
che sta nel cuore dell’uomo. È, come la fede, Dono (di Dio)
e conquista (dell’uomo).
Solitamente si usa contrapporre il termine pace a quello di guerra. In
un certo istante, cessa la pace e inizia la guerra. In un altro momento,
come per incanto, cessa la guerra e inizia la pace. In realtà la
guerra non potrebbe nascere da una situazione di pace. La guerra “scoppia”
quando, da tanto tempo, si è smarrito il senso della pace; quando
si è ignorato o rifiutato il Dono e si è abdicato all’impegno,
quando è venuto meno il coraggio di volere e conquistare la pace.
 La
pace richiede molto coraggio. Come ci ricorda Giovanni Paolo II, la pace
si fonda sulla giustizia e sul perdono. Tutti quanti sappiamo come sia
difficile essere giusti quando si è parte in causa: la pace esige
il coraggio di rinunciare al proprio punto di vista per assumere quello
dell’altro. Tutti quanti sappiamo come sia difficile chiedere e concedere
il perdono, quando si è convinti di aver ragione e di aver subito
un grave torto: la pace esige il coraggio di assumere un superiore criterio
di giudizio.
La
pace richiede molto coraggio. Come ci ricorda Giovanni Paolo II, la pace
si fonda sulla giustizia e sul perdono. Tutti quanti sappiamo come sia
difficile essere giusti quando si è parte in causa: la pace esige
il coraggio di rinunciare al proprio punto di vista per assumere quello
dell’altro. Tutti quanti sappiamo come sia difficile chiedere e concedere
il perdono, quando si è convinti di aver ragione e di aver subito
un grave torto: la pace esige il coraggio di assumere un superiore criterio
di giudizio.
La pace non si contrappone soltanto alla guerra guerreggiata. La pace,
che nasce e vive nel cuore dell’uomo, viene meno ogni qual volta
si dia spazio a rancori, desideri di rivalsa, diffidenze, pregiudizi,
semplice noncuranza. Ogni volta che si persegua un interesse, anche legittimo,
senza sufficiente attenzione ai diritti degli altri; quando si accettano
privilegi o semplicemente usi, costumi e regole di convivenza basati sull’ingiustizia.
Insomma la battaglia per la pace è una battaglia giusta, anzi santa,
da combattere prima di tutto con sé stessi. L’annuncio, la
testimonianza, la missione che siamo chiamati a vivere tutti i giorni
(ora), nel nostro ambiente familiare, professionale, sociale (qui), a
beneficio di chi ci è vicino, presuppone, prima ancora del nostro
dire, che il nostro essere, il nostro pensare e il nostro fare, nascano
da un cuore pieno di pace.q